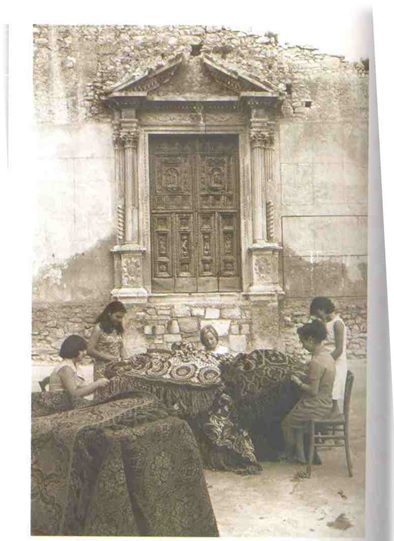Parlare di partecipazione femminile al mercato del lavoro significa affrontare un tema complesso e dalle molteplici sfaccettature, soprattutto nei Paesi dell’area mediterranea e, in particolare, in Italia.
Gli ultimi dati disponibili per il nostro Paese, contenuti all’interno di un recente rapporto ISTAT-CNEL, presentato il 6 marzo 2025, evidenziano come nel terzo trimestre 2024 il tasso di occupazione femminile risulti inferiore di 12,6 punti rispetto alla media UE27 e alla Francia, e di 20 punti rispetto alla Germania, rimanendo il valore più basso tra i ventisette paesi dell’Unione europea. Non solo: il gap retributivo di genere, ovvero il differenziale stipendiale medio fra uomini e donne a parità di ruolo, mantiene valori marcati in diversi settori produttivi, in particolare nel campo delle attività finanziarie, assicurative e dei servizi alle imprese, dove si registra un divario di oltre trenta punti percentuali fra i due generi.
Il dato è strettamente correlato alla persistente sottorappresentazione delle donne nelle posizioni apicali e di leadership aziendale dei contesti organizzativi pubblici e privati: nonostante gli sforzi compiuti da legislatore per assicurare l’equilibrio di genere all’interno degli organi di rappresentanza e amministrazione delle società quotate, infatti, nel 2024 in Italia solo il 2,9% degli amministratori delegati è donna a fronte di una media UE27 del 7,8%, del 21,1% della Lituania, che guida la classifica. Le disparità restano enormi anche se si guarda ai direttori d’azienda: di nuovo l’Italia si colloca nelle posizioni di coda della graduatoria dei Paesi Ue con il 15,6% dei dirigenti donna, a considerevole distanza dalla media UE27 del 22,7%, ma soprattutto da Paesi come la Lettonia o la Francia, in cui le donne che guidano un’impresa quotata in borsa rappresentano rispettivamente il 32,1% e il 29,9%.
L’indagine sul perché l’Italia sconti ancora forti ritardi in tema di partecipazione femminile al mercato del lavoro non può, tuttavia, fermarsi qui. Analizzare il problema unicamente dalla prospettiva della bassa occupazione o delle differenze salariali, che pure costituiscono una delle sue dimensioni primarie, potrebbe infatti risultare riduttivo se, contestualmente, non si affrontano le ragioni che rendono l’occupazione femminile strutturalmente più vulnerabile di quella maschile.
Sarebbe forse corretto chiedersi, dunque, perché una donna è più portata di un uomo ad abbandonare il mercato del lavoro in giovane età o a stipulare contratti di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato. Perché, ad un certo punto della sua vita lavorativa, anziché optare per un avanzamento di carriera le donne lasciano il loro posto di lavoro o riducono il tempo lavorato accettando, di conseguenza, salari più bassi. Perché, infine, nonostante siano mediamente più istruite degli uomini, le donne faticano a trovare lavori ad alta specializzazione, in particolare nel campo STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).
In linea gli ormai consolidati studi di settore, una possibile risposta può essere trovata nelle disparità strutturali che permeano il mercato del lavoro italiano e dell’area europea – mediterranea (Grecia e Spagna, in particolare), contraddistinta da caratteristiche socio-demografiche, geografiche e culturali simili. In primis, la radicata presenza di modelli di organizzazione sociale cosiddetti male bradewinner, dove è consolidato il ruolo dell’uomo all’interno dei nuclei familiari e della società più in generale, come capofamiglia e principale fonte di reddito, e della donna come caregiver, addetta ai lavori di cura della famiglia, dei figli e della casa, in generale. Se con l’avvio del processo di de-industrializzazione e l’avvento della globalizzazione questi modelli hanno iniziato a vacillare, il retaggio culturale che ne è alla base è ancora di là dallo scomparire: la gestione di figli e dei familiari anziani e non autosufficienti ricade, infatti, ancora in larga parte sulle donne. Secondo il report elaborato dal CNEL lo scorso 18 ottobre 2024 sul valore dei caregiver, in Italia, gli oltre 7 milioni di caregiver sono in maggior parte donne (58%), con un’età compresa tra 45 e 64 anni (56%) e per la metà composta da occupati, mentre il 37% risulta fuori dal mercato del lavoro. Di qui, la difficoltà dichiarate nel conciliare gli impegni lavorativi con le responsabilità di cura, che rappresentano, in oltre il 70% dei casi la motivazione primaria di abbandono del lavoro. La questione è inevitabilmente connessa alla disponibilità di una efficiente rete pubblica di servizi alla persona e alla famiglia (asili nido, scuole d’infanzia a tempo pieno, assistenza domiciliare per anziani, mobilità pubblica…): in Italia solo il 28,1% dei bambini sotto i 3 anni ha accesso a servizi educativi per la prima infanzia, con coperture particolarmente basse nelle regioni del Mezzogiorno (appena il 17% circa, segnale di un’offerta carente).
Questa mancanza ha riflessi diretti nelle scelte lavorative: secondo la relazione annuale sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri elaborata dall’Ispettorato del Lavoro, nel 2024 su oltre 60.000 recessi, 18.519 (30,5% del totale) si riferiscono a uomini e 42.237 (69,5% del totale) si riferiscono a donne. Per queste ultime, la motivazione prevalente di abbandono del lavoro è la difficoltà di conciliazione tra lavoro e cura della famiglia: in particolare la maggioranza delle lavoratrici madri ha collegato tale difficoltà all’assenza di servizi (il 45,2% nel 2023, il 47,5% nel 2024), seguita dalle criticità legate all’organizzazione del lavoro, come orari di lavoro poco flessibili, assenza di modalità di lavoro agile e lunghe distanze casa-lavoro (29,5% nel 2023 e 30,0% nel 2024).
Il quadro si complica maggiormente se letto alla luce delle disparità di carattere territoriale che caratterizzano il nostro Paese: nel secondo trimestre 2024, al Nord risultavano occupate il 62,4% delle donne con un’età compresa tra 15 e 64 anni, quota che scende al 60,8% nel Centro e diviene poco più di un terzo nel Mezzogiorno (36,9%). Di queste, solo il 40% sono madri, a fronte del 70% delle occupate al nord Italia.
Il dato migliora, però, se si guarda al livello di istruzione posseduto: all’aumentare del titolo di studio aumenta la quota di occupate e diminuisce il gap tra le donne senza figli e quelle con figli, in tutte le classi di età. La distanza più ampia (oltre 20 punti percentuali) riguarda, di nuovo, le giovani madri (25-34 anni) con al massimo la licenza media, il cui tasso di occupazione non raggiunge il 30%.
Queste condizioni, sommate fra loro, generano un cortocircuito occupazionale che penalizza fortemente la forza lavoro femminile, soprattutto in periodi di crisi o in presenza di particolari esigenze contingenti. Le donne sono “le ultime ad entrare e le prime ad uscire dal mercato”, poiché il loro lavoro è spesso considerato secondario, alla luce della maggiore precarietà contrattuale che lo caratterizza e della minore remuneratività ad esso associata, motivo per il quale il potenziale professionale femminile viene sacrificato più facilmente all’aumentare dei carichi familiari. Ciò perpetua l’esclusione femminile dal mercato del lavoro e amplia il divario di genere nel lungo periodo.
Passando alle soluzioni, consci che non esista un’univoca e immediata strategia di contenimento del fenomeno, è possibile individuare due importanti aree di intervento: la prima ha a che fare con la costruzione di una capillare rete di welfare, che garantisca sempre maggiori possibilità di accesso a servizi per l’infanzia e di assistenza domiciliare. Investire in politiche mirate di conciliazione e nel potenziamento dei servizi pubblici consente, nel lungo periodo, di evitare la dispersione del potenziale professionale femminile e ottenere un ritorno economico non indifferente, per il tessuto imprenditoriale e per il territorio, nel suo complesso. A ciò si aggiunga la possibilità che anche le aziende private incentivino politiche di welfare integrativo a beneficio dei dipendenti, incoraggiando la costruzione di un ambiente di lavoro sano e improntato al benessere della persona: favorire l’accesso a congedi e permessi legati alla genitorialità e alla famiglia, promuovere orari flessibili e lavoro agile e attivare servizi aziendali di childcare può diventare un modo per migliorare l’equilibrio tra vita privata e professionale e disincentivare l’abbandono e il turnover.
La seconda area di intervento riguarda la diffusione di maggiori livelli di scolarizzazione e la facilitazione dell’accesso a percorsi di istruzione di secondo livello. Come visto, la vulnerabilità lavorativa si riduce significativamente all’aumentare del livello di istruzione, motivo per il quale è fondamentale, soprattutto nel Mezzogiorno dove si scontano maggiori carenze, promuovere politiche educative e formative improntate all’inclusione e alla professionalizzazione per tutte le età e in tutti i settori, in specie in quelli scientifici e tecnici, dove la presenza femminile fatica ancora a decollare.
In conclusione, la scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro in Italia non è solo il risultato di divari salariali o occupazionali, ma il frutto di barriere culturali, sociali e organizzative che ostacolano l’inclusione piena e duratura delle donne nel contesto occupazionale e rafforzano il cosiddetto soffitto di cristallo, una barriera invisibile ma resistente, che, ogni donna vede al di sopra di sé quando compie scelte legate alla sua professione. Superare tali ostacoli significa non solo raggiungere obiettivi legati all’equità e garantire l’accesso reale a pari opportunità lavorative, ma favorire la crescita economica del paese nella sua interezza, attraverso la piena valorizzazione del proprio capitale umano femminile.